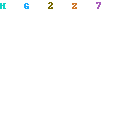L'Associazione TerrAnomala con il progetto Carne Da Macello, si impegna attraverso conferenze e dibattiti a mettere in evidenza diversi aspetti per cui la violenza materiale e culturale sulle
donne si intreccia con lo sfruttamento degli animali non-umani. È noto
come tutte le forme di discriminazione tra esseri umani venga
preferibilmente formulata in termini di “animalizzazione” dell’altro:
cioè, sulla base della distinzione gerarchica tra umano e non-umano,
tutti i soggetti che socialmente occupano una posizione inferiore
rispetto ai soggetti dominanti, subiscono una degradazione simbolica e
vengono considerati quasi-umani, sub-umani o esplicitamente animali.
Ciò è evidente nel caso della xenofobia che, fin dal tempo degli
antichi greci, faceva considerare le altre etnie incapaci di parlare in
modo proprio (è il significato originario del termine “barbaro”) o di
controllarsi in modo razionale (vedi i comportamenti “bestiali” che
ancora oggi i media attribuiscono ai migranti). Ma anche nel caso del
sessismo e della discriminazione di genere è accaduto qualcosa di
simile: sempre i greci consideravano la donna un essere non pienamente
razionale (una forma di maschio “mancato”), più legata all’istinto e
alla natura animale rispetto al maschio. Anche in questo caso, alcune
differenze reali tra i sessi venivano (e vengono) usate per marchiare il
corpo della donna con il sigillo della “inferiorità”: così le
mestruazioni dovrebbero mostrare questo maggior “legame” della donna
alla natura (mentre il maschio si auto-rappresenta come essere
“spirituale”, sganciato dalla fisicità); oppure la sensibilità
femminile, la capacità empatica, la cura ecc. vengono considerate dei
“difetti” invece che delle qualità. Un eccesso di emotività che
impedisce alla donna di essere pienamente razionale e, dunque,
pienamente umana, poiché la tradizione patriarcale identifica l’umano
con i tratti caratteristici del maschio (la contrapposizione
mente-corpo, la maggiore importanza attribuita ad una razionalità
sganciata dall’emotività, l’aggressività competitiva contrapposta alla
capacità di ascolto e di immedesimazione con l’altro ecc.). Non è un
caso che la prima formulazione dei “diritti animali” fu elaborata in
modo sarcastico dal filosofo inglese Thomas Tylor nel 1792 come risposta
alla richiesta di diritti per le donne da parte di Mary Wollstonecraft:
se concediamo diritti alle donne, sosteneva Tylor, perché non farlo
anche con gli animali?
Questo legame simbolico tra sfruttamento
animale e discriminazione femminile viene poi evidenziato oggi dal modo
in cui il linguaggio patriarcale pensa la donna. La femminista americana
Carol J. Adams ha mostrato quanto spesso il linguaggio (non solo
pubblicitario) tenda a rappresentare la donna in forma di pezzi di
“carne”: la donna è spesso desiderata dal maschio non come una persona
ma come un insieme di particolari che possono soddisfarne il piacere.
Inversamente, la cultura patriarcale si è spesso accompagnata ad una
cultura della carne intesa come trofeo ideale per il maschio dominante:
simbolo che ne rinforza il potere. Già nelle società di
cacciatori-raccoglitori in cui la divisione tra i generi si è sviluppata
più nettamente, questo predominio del maschio si costruisce proprio
sulla re-distribuzione della carne che viene fatta dopo la caccia,
redistribuzione in cui al maschio spetta ovviamente la parte maggiore
della preda.
Infine, si può ricordare come l’allevamento sorga
proprio controllando la funzione riproduttiva degli animali non-umani e
come la “cultura del latte” costituisca uno sfruttamento feroce delle
caratteristiche “materne” della specie bovina
Translate

Attivismo
- Allevamenti (8)
- Ambiente e Veleni (1)
- caccia (14)
- Campi Antibracconaggio (29)
- Circhi e Zoo (10)
- Delfinari e Parchi Acquatici (3)
- Eventi (31)
- Feste e Sagre - La Tradizione Violenta (5)
- le nostre attività (10)
- Operazione Bosco Vivo (2)
- Operazione Bufo Bufo (14)
- Operazione Roma Pulita (5)
- Operazione un terreno senza cacciatori (2)
- Palii (5)
- Pellicce (4)
- Segnalazioni Maltrattamenti ed Illeciti (10)
- Soccorso Fauna Selvatica (16)
- Varie ed Eventsugli AnimaliNonUmani (3)
- Varie ed Eventuali sugli AnimaliNonUmani (13)
- vivisezione (1)
Categorie
Iscriviti alla Newsletter
Powered by Blogger.
Links
- Animal Equality Italia
- Campagne Per Gli Animali
- Collettivo Antispecista Brescia
- Coordinamento Contro il MegaMacello
- Fabbriche Di Carne
- Fermare Green Hill
- Fino alla Fine
- Informa-Azione
- Lega Abolizione Caccia
- Liberazioni
- Mappa Vegana Italiana
- Nemesi Animale
- Oltre La Specie
- Per Animalia Veritas
- Progetto Vivere Vegan
- Rewild Cruelty-free Club
- VeganRiot
- Vegani Antispecisti Informali
- Veganzetta
- Villa Vegan Squat
Modulo di contatto
Archivio
- marzo 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (1)
- marzo 2019 (2)
- gennaio 2019 (4)
- dicembre 2018 (2)
- settembre 2018 (1)
- giugno 2018 (3)
- marzo 2018 (1)
- dicembre 2017 (1)
- settembre 2017 (1)
- maggio 2017 (1)
- aprile 2017 (1)
- gennaio 2017 (1)
- novembre 2016 (1)
- ottobre 2016 (2)
- giugno 2016 (1)
- maggio 2016 (1)
- febbraio 2016 (1)
- dicembre 2015 (1)
- agosto 2015 (1)
- marzo 2015 (2)
- febbraio 2015 (2)
- dicembre 2014 (3)
- ottobre 2014 (1)
- settembre 2014 (2)
- agosto 2014 (1)
- maggio 2014 (2)
- marzo 2014 (3)
- gennaio 2014 (2)
- dicembre 2013 (3)
- settembre 2013 (2)
- agosto 2013 (1)
- luglio 2013 (2)
- giugno 2013 (2)
- maggio 2013 (1)
- marzo 2013 (2)
- febbraio 2013 (1)
- gennaio 2013 (1)
- dicembre 2012 (3)
- novembre 2012 (4)
- ottobre 2012 (4)
- settembre 2012 (1)
- agosto 2012 (1)
- giugno 2012 (3)
- maggio 2012 (3)
- aprile 2012 (1)
- marzo 2012 (5)
- febbraio 2012 (1)
- gennaio 2012 (3)
- dicembre 2011 (3)
- novembre 2011 (2)
- ottobre 2011 (2)
- settembre 2011 (4)
- agosto 2011 (4)
- luglio 2011 (4)
- giugno 2011 (4)
- maggio 2011 (5)
- aprile 2011 (6)
- marzo 2011 (3)
- febbraio 2011 (4)
- gennaio 2011 (4)
- dicembre 2010 (4)
- novembre 2010 (6)
Associazione Terranomala Onlus - InformAzione Diretta per la Liberazione Animale. Copyright 2009 All Rights Reserved Free Wordpress Themes by Brian Gardner Free Blogger Templates presents HD TV Watch Shows Online. Unblock through myspace proxy unblock, Songs by Christian Guitar Chords